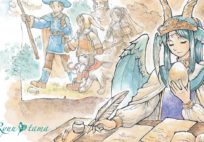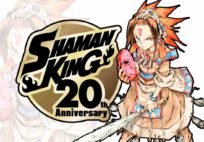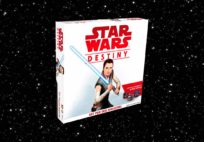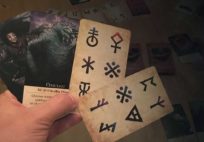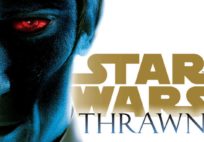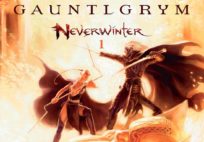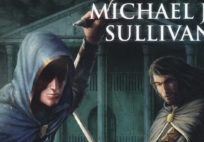I videogames hanno modificato l’approccio alla creatività imponendo stereotipi e sviluppando canoni mitologici. Ma hanno davvero spento l’immaginazione degli appassionati? Cerchiamo di fare il punto.
I videogames hanno modificato l’approccio alla creatività imponendo stereotipi e sviluppando canoni mitologici. Ma hanno davvero spento l’immaginazione degli appassionati? Cerchiamo di fare il punto.
L’evoluzione è inevitabile: come ogni cosa, anche il fantasy ha subito notevoli modifiche di genere sin dalla sua “nascita”, quando un tale decise di buttar giù la più grande epopea contemporanea dal suo studio di Oxford. Oggi è difficile tracciare una linea chiara su cosa sia fantastico e cosa non lo sia, e gli esempi possono essere molteplici.
Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco hanno virato verso una dimensione più realistica che un determinato gruppo di followers – me compreso – non ha digerito tanto bene. Naturalmente questo non per presunzione né per una qualunque forma di chiusura verso il nuovo, ma perché George Martin ha spezzato alcuni cliché senza forse comprendere che in realtà la morale della favola nelle fiabe per adulti è assolutamente fondamentale e che senza quest’ultima si può soltanto puntare a un gran bel romanzo.

Skyrim (nello specifico, il DLC Dragonborn).
Tuttavia, possiamo notare nuove forme di esperimenti fantasy anche, e soprattutto, nelle moltissime piattaforme di intrattenimento di cui oggi possiamo godere, tra cui quella videoludica. A partire dalle prime esperienze di action roleplay game su PC, in due/tre decenni le software house hanno sfornato titoli sempre più appetibili fino a toccare punte di elevatissima qualità che però molti puristi hanno tacciato come ammazza-fantasy: questo perché l’idea del pixel programmato fa troppa paura a chi è abituato a scrivere e disegnare su di un quaderno qualunque cosa gli venga in mente a partire da un manuale cartaceo.
Ritengo che in realtà si tratti di due esperienze profondamente diverse e che entrambe possano essere prese per il verso sbagliato. Non sono abituato a vivere di assoluti (cit.) e questo atteggiamento mi ha sempre aiutato a criticare le mie stesse passioni con mediocre lucidità: esiste un universo fatto di week-end con gli amici, musica d’ambientazione epica o demenziale – a seconda della compagnia che si frequenta –, Dungeon Master e prodi avventurieri che, armati di pesanti matite e lucenti righelli, affrontano sfide che soltanto un profondo scrutamento della psiche umana potrebbe spiegare, e che molto spesso si dimostrano divertenti fun encounters, dove grosse e grasse risate fanno da contorno a un’esperienza di per sé assolutamente seriosa.

Pedine, amici e patatine possono soppiantare un solitario videogame?
D’altro canto, esiste anche un universo fatto di esplorazioni in solitaria, dialoghi pre-impostati nei quali possiamo a malapena decidere del nostro fato già scritto, ma del quale, come quando siamo in procinto di voltare pagina al nostro libro del mese – è vero che leggiamo almeno un libro al mese, vero?!? –, siamo a tal punto affascinati da non voler mai smettere. E questo non vuol dire che ci stiamo tutti trasformando in giocatori da strapazzo fatti con lo stampino, ma che in quel preciso istante immaginiamo d’essere prodi guerrieri sprezzanti del pericolo o maghi arcani dalla dubbia natura morale, a seconda del libro interattivo che siamo in procinto di leggere.
Non dobbiamo quindi contrapporre il nostro ego intellettivo al mutamento, ma essere in grado di farlo relazionare con una differente visione della mitopoiesi, che però può risultare altrettanto stimolante sia per il lettore che per il creatore di mondi e visioni. D’altronde se vogliamo che il genere non subisca un lento e inesorabile declino dobbiamo mettere in discussione anche le sue stesse fondamenta.

Morire al tavolo, o su uno schermo, fa male uguale?
Il reale dilemma che dovremmo porci come “addetti ai lavori” secondo me è il seguente: siamo in grado di riprogettare le fondamenta del fantasy moderno? Siamo in grado di conciliare i mutamenti psico-sociali degli users con l’originale approccio della simbologia narrativa targata, per esempio, Tolkien e Lewis?
Ho vissuto oramai per un quarto di secolo e non posso negare di averne viste di belle e di brutte, anche negli ambienti dell’immaginario simbolico. Nutro però grandi speranze proprio perché vedo – e tocco con mano – quanta creatività ci sia a partire dal basso, dalla community che alimenta quest’enorme circolo dalle dimensioni oramai globali.
In fondo non è importante vedere un drago rosso o nero, ma scrutarne comunque l’ombra.
-Pasquale Palma-